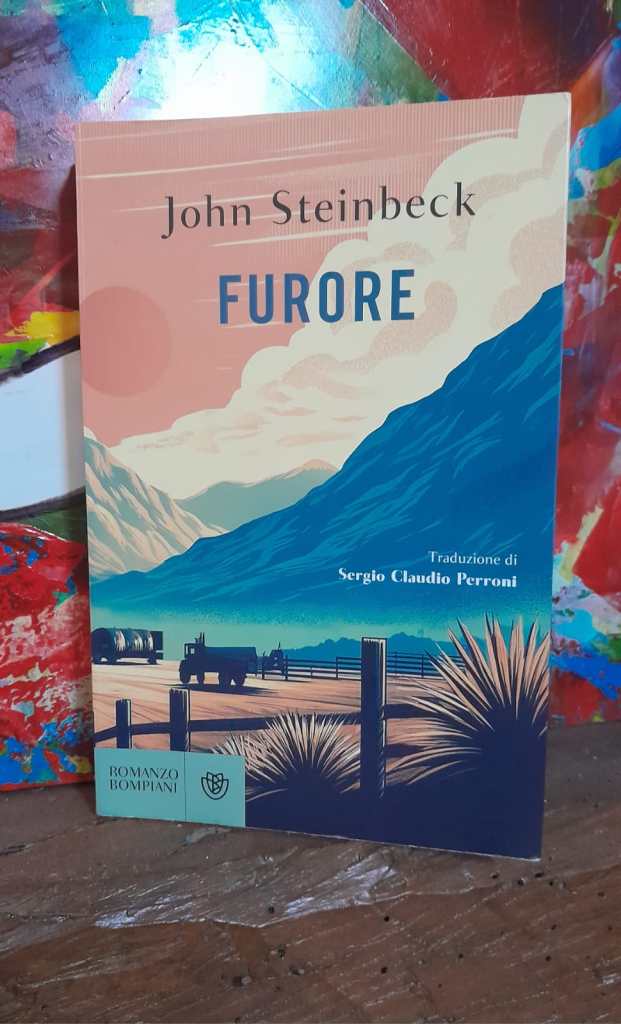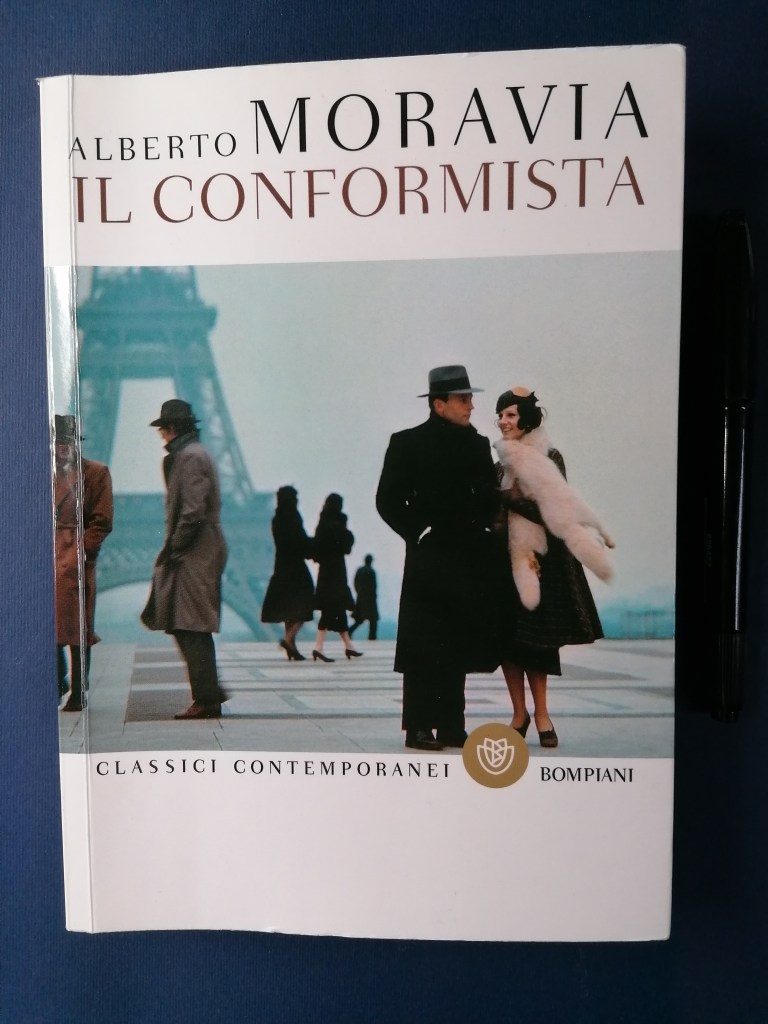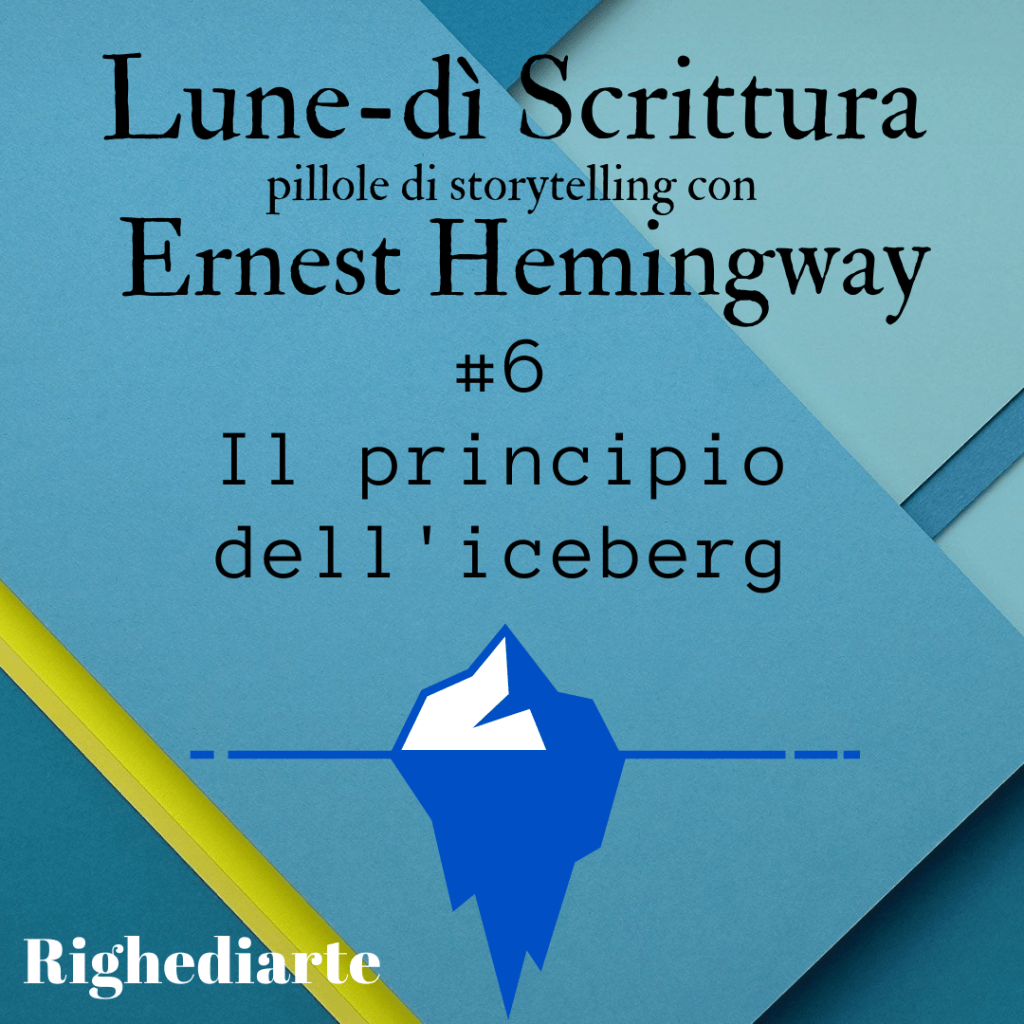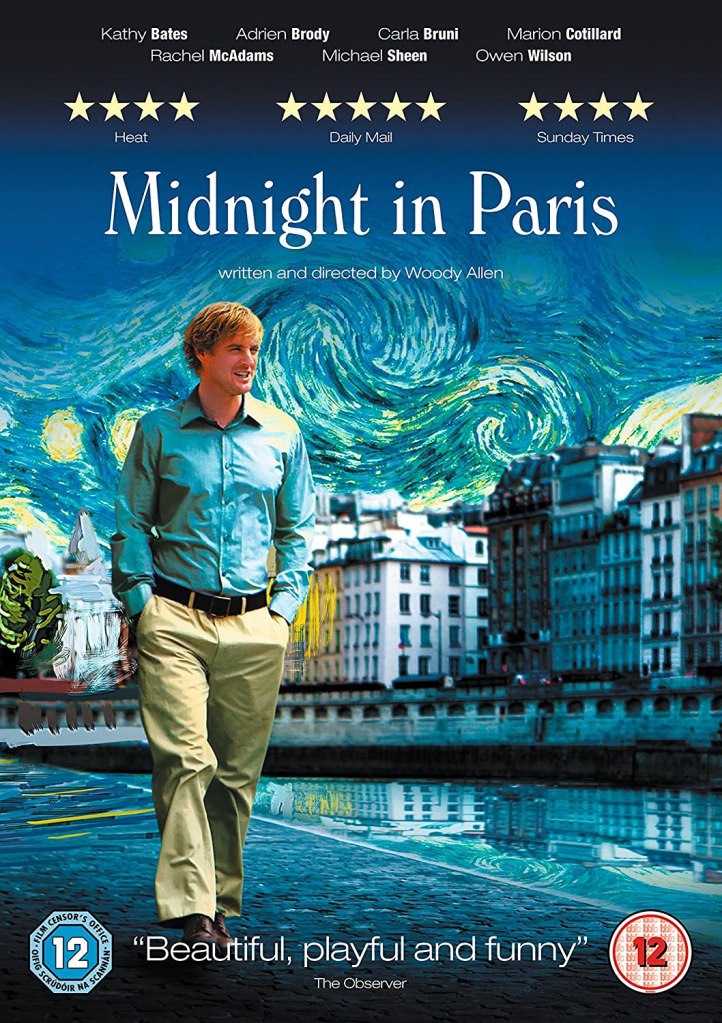“La voce narrativa riguarda chi parla, mentre la focalizzazione riguarda chi vede: due domande essenziali per comprendere il funzionamento di ogni racconto.”
Gérard Genette
I giorni che precedono il Natale e il mese di dicembre rappresentano solitamente il periodo delle tradizioni ritrovate. Non mi riferisco in questo caso all’albero di Natale, che almeno a casa mia si fa rigorosamente l’8 dicembre, ma ai miei amati Lune-dì scrittura: quello spazio di Righe di arte dedicato al piacere di esplorare i meccanismi della narrazione. Piacere che per un po’ (un bel po’) ho lasciato nel cassetto, ma che oggi riprendo con ritrovato entusiasmo.
Ti ricordi la professoressa di letteratura delle medie che con voce squillante e una dizione impeccabile, assegna il compito: “Brano a pagina 54: indica la voce narrante e specifica se è in prima persona o onnisciente”? Ecco, in questo lunedì affronto un aspetto che, ai tempi delle scuole medie, sembrava soltanto un esercizio noioso: individuare la voce narrante in una storia, e il concetto di focalizzazione in una storia. Spero in modo meno odioso della prof delle medie però.
Questi due concetti, insieme a quelli di fabula e intreccio e ai meccanismi narrativi di analessi (flashback) e prolessi (flashforward), costituiscono la base della teoria elaborata da Gérard Genette, teorico della narratologia, nel suo famoso saggio Discorso del racconto (Figure III, 1972).
Partiamo dalla voce narrante, elemento cruciale per comprendere a fondo un’opera letteraria, e anche elemento caratterizzante di molti capolavori della narrativa mondiale.
Ti immagi Il giovane Holden scritto in terza persona? Non suona per niente, vero?
Oppure Moby Dick che comincia con “Lo chiamano Ismaele” (sembra la parodia di “Lo chiamavano Trinità”)
Suonerebbero come delle forzature, un po’ come chiedere al buon Tolkien di tagliare qualche descrizione o a King di essere più sintetico.
Il punto di vista e la focalizzazione sono strumenti narrativi essenziali, veri e propri riflettori che l’autore punta su personaggi ed eventi per guidarci attraverso l’intreccio, creare suspense, dare tridimensionalità alla storia stessa. Una scelta che non è mai frutto del caso, lo sa bene chi ha frequentato coesi di scrittura creativa. È la chiave che plasma il racconto, anche se la maggior parte delle volte non ce ne rendiamo conto, rapiti dal meccanismo basico della sospensione dell’incredulità, dal suono delle parole, dalla bellezza o dalla forza dei personaggi.
Ma quanti sono i punti di vista nella narrativa? Le categorie principali sono tre, vediamole.
Narrazione in prima persona
O narrazione interna, dal punto di vista del protagonista o di un personaggio.
Serve ovviamente ad avvicina il lettore alla soggettività dell’esperienza. Romanzi appunto come Il giovane Holden di Salinger utilizzano questa tecnica per immergere il lettore nei pensieri più intimi dei protagonisti, amplificando emozioni e conflitti interiori. È la forma utilizzata nel diario, nell’autobiografia e nel romanzo epistolare. Memorie di Adriano, capolavoro della letteratura del Novecento, frutto di un lavoro quasi ventennale di Marguerite Yourcenar, è costruito come una riflessione intima e personale dell’imperatore romano e si presenta appunto come una narrazione in prima persona, in cui la voce narrante è uno degli elementi più affascinanti e significativi, in cui il protagonista, ormai prossimo alla morte, ripercorre la sua vita e le sue scelte politiche, filosofiche e spirituali.
Narrazione in seconda persona
Molto rara, ma esiste. Il caso più famoso è opera di un autore a me molto caro: Italo Calvino con il suo Se una notte d’inverno un viaggiatore. Devo ammettere che, proprio per la complessità legata al punto di vista narrativo, questo romanzo non rientra tra le mie opere preferite di Calvino (Italo perdonami). Tuttavia, resta affascinante per come coinvolge il lettore stesso, rendendolo protagonista della storia, rompendo la quarta parete e giocando abilmente con la metafiction.
Narrazione in terza persona
Qua le cose si fanno più articolate: il narratore può sapere tutto, vedere tutto e rivelare i pensieri e le azioni di qualsiasi personaggio. Questa scelta offre una visione globale della storia, permettendo una comprensione approfondita degli eventi e delle dinamiche tra i personaggi. Tuttavia, rischia di creare una certa distanza emotiva, poiché il lettore non si immedesima direttamente in un solo punto di vista, e potrebbe ridurre il gusto per i colpi di scena se gestita in modo troppo esplicito.
Una narrazione onnisciente può essere alternata a momenti di focalizzazione interna su singoli personaggi, bilanciando la prospettiva globale con un’immersione emotiva più profonda.
Un aspetto interessante della narrazione in terza persona è la possibilità di modulare il grado di focalizzazione, il secondo concetto di oggi e di cui parlerò nella seconda parte del post.
Narrazione con punto di vista multiplo
La narrazione con punto di vista multiplo è una tecnica che permette di raccontare la storia attraverso le prospettive di diversi personaggi, offrendo una visione sfaccettata della realtà. Autori come Virginia Woolf utilizzano questa tecnica per passare fluidamente da un personaggio all’altro, svelando prospettive diverse su uno stesso evento. Questo approccio riflette la complessità della percezione umana e sottolinea come ogni individuo interpreti la realtà in modo unico.
Ovviamente ogni scelta narrativa comporta vantaggi e rischi. Il punto di vista multiplo consente di arricchire la narrazione, aggiungendo profondità psicologica ai personaggi e offrendo una comprensione più completa della trama. Tuttavia, se non gestito con attenzione, può causare confusione nel lettore o frammentare il ritmo del racconto.
Uno degli aspetti più delicati di questa tecnica è decidere se ogni personaggio rappresenti un narratore attendibile o inattendibile. Un narratore attendibile offre una visione coerente e credibile degli eventi, mentre un narratore inattendibile, spesso influenzato da pregiudizi o limiti di comprensione, genera dubbi e suspense, costringendo il lettore a interrogarsi su ciò che è reale e cosa invece non lo è.
Focalizzazione: cosa vediamo?
La focalizzazione è una vera e propria regia narrativa: decide cosa mettere a fuoco e cosa lasciare nell’ombra, influenzando così la percezione del lettore. È un po’ come camminare in una galleria d’arte con una torcia: puoi vedere solo ciò che la luce illumina, e ogni dettaglio nascosto crea curiosità o tensione. Questa selettività non è solo uno strumento tecnico, ma un mezzo per costruire suspense, generare empatia o offrire una visione parziale che invita a indagare oltre.
Se la voce narrante risponde alla domanda chi racconta la storia, la focalizzazione si occupa di cosa viene raccontato. Gérard Genette, individua tre tipi principali di focalizzazione:
- Focalizzazione zero:
Il narratore sa tutto, è una mente onnisciente, in grado di esplorare i pensieri, i sentimenti e i segreti di tutti i personaggi, così come di rivelare dettagli sull’ambientazione o anticipare eventi futuri, come accadeva nella maggior parte dei romanzi ottocenteschi dove l’autore ha un controllo assoluto sul mondo narrativo. Si tratta di un approccio che, se non gestito sapientemente può risultare pesante e togliere effetto sorpresa e immediatezza dell’esperienza.
- Focalizzazione interna:
Con questa tecnica, il narratore vede e sa solo ciò che conosce un determinato personaggio. È il caso di La solitudine dei numeri primi, di Paolo Giordano dove il mondo viene filtrato attraverso gli occhi dei due protagonisti Alice e Mattia. Questo tipo di focalizzazione crea un forte senso di immedesimazione, ma limita il lettore a una prospettiva parziale.
- Focalizzazione esterna:
In questo caso, il narratore è un osservatore esterno e si limita a descrivere ciò che può essere visto o sentito dall’esterno, senza accedere ai pensieri o alle emozioni dei personaggi. Questo stile, tipico del minimalismo di autori come Kent Haruf, somiglia al punto di vista di una telecamera: registra azioni e dialoghi senza spiegare troppo, lasciando al lettore il compito di interpretare.
La scelta della focalizzazione non è mai neutrale: ha un impatto diretto sulle emozioni del lettore. La focalizzazione interna, ad esempio, può generare empatia e coinvolgimento, immergendo il lettore nei conflitti interiori di un personaggio. Al contrario, la focalizzazione esterna spesso crea un effetto di distacco, ma può anche accrescere il mistero o la tensione, poiché lascia in sospeso ciò che i personaggi pensano davvero. La focalizzazione zero, infine, trasmette un senso di controllo e chiarezza, ideale per storie epiche o corali, ma può risultare meno intensa dal punto di vista emotivo (e forse anche troppo scontata, bisogna sempre nascondere qualcosa al lettore…).
In definitiva, la focalizzazione è un ingrediente cruciale della narrazione, una lente che definisce non solo cosa il lettore vede, ma come lo vede. Saperla gestire significa avere il controllo dell’attenzione e delle emozioni del lettore, guidandolo attraverso la storia come un regista guida la sua telecamera in un film. E, come ogni grande regista che sapientemente muove una telecamera, un buon narratore sa che a volte è soprattutto ciò che non si mostra a fare la differenza.
In conclusione, chi vuole approcciarsi alla narrativa deve sapere che la scelta della voce narrante e la focalizzazione sono le prime e cruciali decisioni per affrontare la narrazione di un racconto o di un romanzo. È attraverso di loro che la storia prende forma, trasformandosi da semplice trama in un’esperienza complessa, stratificata, plurisensoriale. La vera magia della letteratura risiede qui, nel modo in cui ogni autore, con la sua “luna” di scrittura, ci mostra mondi nuovi attraverso occhi diversi, rendendoci partecipi del suo viaggio.
Se ti è piaciuto il post, ricorda di seguire Righe di Arte con il tuo account di WordPress o inserendo il tuo indirizzo email nella sezione “Segui questo blog”. In questo modo riceverai una notifica ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti.
Trovi@righediarte anche su Facebook e Instagram.
Paola Cavioni, 2 dicembre 2024